il film mibac - visiogeist a venezia 2014

Visiogeist va alla Mostra del Cinema di Venezia principalmente per Houellebecq e ovviamente per vedere la Rohrwacher in Hungry Hearts, intanto però non poteva sfuggirci questo gioiellino di Andrea Minuz in veste di anatomopatologo del film Mibac.
«Arianna è una scrittrice che vive in un esilio volontario a Santa Marinella, sul litorale laziale, dopo che il marito, uomo politico più importante di lei, l'ha lasciata. Ma un giornalista bussa alla sua porta…». Due dita di plot di Nessuno mi pettina bene come il vento e siamo già lì, sprofondati nell'universo del Film Mibac. Lo chiameremo così.
Il Film Mibac è il film «d'interesse culturale» prodotto, sostenuto, finanziato e detassato dallo Stato (Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale per il Cinema), in accordo con RaiCinema e varie Film Commission regionali a seguire, a seconda dei casi. Che vuol dire quasi tutto il cinema italiano, tolto Checco Zalone e poco altro. Sul destino dei film di Zalone decide il pubblico. Ma Nessuno mi pettina bene come il vento è un'«opera riconosciuta di interesse culturale», liberata dalla schiavitù del mercato e dai gusti orrendi del botteghino. Letteratura, abbandono, esilio, politica, giornalismo, litorale laziale. C'è tutto quello che serve per fare un Film Mibac. Così sentenzia una commissione statale che gli assegna in automatico un finanziamento. Scarso, secondo il regista del film Peter Del Monte: «I miei soggetti nascono molto cupi. Posso pensare di trovare un finanziamento solo dallo Stato, ma questa volta mi hanno dato solo duecentomila euro». Perché a volte lo Stato è insensibile alla cupezza di Santa Marinella. Perché non è mica facile capire quando un film è un'opera «d'interesse culturale». Provateci voi.
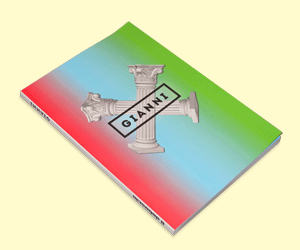
Di sicuro, non è che coi soldi pubblici possiamo produrre L'uomo ragno. The Wolf of Wall Street, manco a parlarne. E se Ermanno Olmi vuole fare un film con gli zombie, la commissione deve rintracciare nel progetto almeno una metafora trasparente della cassa integrazione, oppure non se ne fa nulla. Come capita in ogni ecosistema, alla fine si trova un equilibrio. C'è «interesse culturale» se c'è disinteresse popolare. Perché il Film Mibac è una visione del mondo. Ha il suo catalogo di temi, figure, motivi. Più elastico di un universo veltronico, è chiamato a tenere assieme i pezzi dell'immaginario di un ceto medio di sinistra che delega allo Stato la definizione della cultura nella sua accezione più distintiva, ricattatoria, sofferente. Che preferibilmente va nei cinema del centro, ama l'etnico, diffida dei multiplex, non mangia i popcorn e al tempo libero chiede contenuti, spessore, qualità, impegno. Se va a vedere una commedia non è mai «solo una commedia».
Il Film Mibac abbraccia la grande stagione del cinema d'autore e l'impulso pedagogico della Rai, l'anticapitalismo e il product placement del «decreto Urbani», la Puglia di Vendola, la Roma di Sorrentino, il Pigneto di Pasolini, il maestro Manzi, Fellini, gli immigrati, la commedia all'italiana, lo smaltimento dei rifiuti, il neorealismo contro tutte le mafie che uccidono solo d'estate in un piano-sequenza della Rohrwacher. E alla fine vengono fuori i temi della maturità.
L'estetica del Film Mibac persegue la «formazione di un identità culturale nazionale attraverso l'industria dell'audiovisivo». Quest'anno escono i temi su Leopardi (Mario Martone, un milione e duecentocinquantamila euro) e Boccaccio (F.lli Taviani, novecentomila euro), che se la vedranno con Lu cunto dei li cunti di Giambattista Basile nella versione di Matteo Garrone (un milione di euro); «la più artistica tra le raccolte di fiabe della nostra tradizione», come diceva Benedetto Croce, presagendo la richiesta di finanziamento pubblico. È la via italiana al blockbuster, con le grandi opere pedagogiche che arrivano puntuali come un'enciclopedia a rate.
Il film di Martone si intitola Il giovane favoloso. Meraviglioso Boccaccio gli fa eco quello dei Taviani. Leopardi e Boccaccio sono i supereroi Mibac. Non salvano la terra, non sconfiggono il Male, però ci riportano tra i banchi di scuola. Come i tanti Film Mibac sulla scuola, narrati spesso, e non a caso, dal punto di vista di professori e professoresse a forma di Silvio Orlando in maniche corte e Margherita Buy col golfino. In alternativa, c'è la lezione di educazione civica. Eutanasia e laicità con Bellocchio e Bella addormentata. Eutanasia e materialismo storico con Miele di Valeria Golino. Il testamento biologico è già epica Mibac. Checco Zalone l'ha capito prima di tutti e in Sole a catinelle ha messo un regista italiano col turbante in testa che sta girando Eutanasia Mon Amour ma interrompe le riprese perché «sente puzza di borghesia». Film italiani tratti da dibattiti italiani che creano dibattiti italiani. Bellocchio spiegò che Bella addormentata non era un film sul caso Englaro, né sull'eutanasia, ma «una metafora sull'Italia di oggi». A Venezia non vinse e ci restò un po' male: «Un membro della giuria ha detto che il cinema italiano sarebbe troppo provinciale, autoreferenziale, non si occuperebbe di temi universali. Di queste imbecillità ne ho piene le scatole. L'eutanasia, il dramma del fine vita sono forse un tema provinciale?». Se me lo racconti con le immagini di repertorio del Tg1 un po' sì. Se fai Million Dollar Baby, no.
Spesso il Film Mibac è «memore della lezione del neorealismo», e allora racconta le mutazioni del paesaggio, le specificità del territorio. In aperta campagna, senza plot, puro cinema e apicoltura nel casale delle sorelle Rohrwacher. E siccome poi dicono che siamo provinciali, allora portiamo Jasmine Trinca in Amazzonia. Decrescita felice, sviluppo sostenibile, ricerca spirituale: «Ora voglio essere terra, devo dimenticarmi di Dio», dice in Un giorno devi andare mentre fugge verso la favela di palafitte di Manaus, lungo il Rio Negro. Lì dove fuggiranno anche gli azzurri di Prandelli. Lì dove Concita De Gregorio da Repubblica scriverà «Hiandra, Adriel, i bambini di Manuas e Balotelli». Nel film di Giorgio Diritti c'erano tutti i nostri Mondiali, come in una visione sciamanica. Mancava solo il morso di Suarez.
Il Film Mibac ripudia il profitto. D'altronde, nessuno glielo chiede. Il codice a barre incombe minaccioso sulle teste dei personaggi del Capitale umano di Virzì. Ma al profitto si oppone l'arte. E quando Valeria Bruni Tedeschi ripudia la finanza coniugale, riemerge dal passato una perduta vocazione teatrale. Si abbandona alle lusinghe intellettuali di Lo Cascio mentre cala, sulla proverbiale scopata d'interesse culturale, la benedicente ombra di Carmelo Bene proiettato alle pareti. L'unico capitale «umano» possibile è quello ministeriale. Settecentocinquantamila euro, sei David di Donatello, sei Nastri D'Argento.
Perché il Film Mibac si fa coi soldi pubblici ma è trasparente. Prima c'era il finanziamento a pioggia. Oggi c'è il reference system. Punteggio automatico assegnato in base a vari parametri «oggettivi», ovvero David di Donatello e Nastri D'Argento nel curriculum. Più premi, più soldi. L'ecosistema premia, approva e produce in un'instancabile catena di incentivi. Meryl Streep non raggiungerebbe i David e i Nastri di Margherita Buy neanche con le nomination ai prossimi dieci premi Oscar. Rispetto al fondo perduto di qualche anno fa però va molto meglio. Ora facciamo le curve d'incidenza. È il socialismo scientifico applicato alle «terrazze romane»™.
Il Film Mibac sente la nostalgia del passato. «Se la sceneggiatura è brutta, ambientalo negli anni Settanta», dice un antico proverbio ministeriale. Ha cominciato Fazio con i Cugini di campagna, poi a ruota il cinema e la fiction e pare non smettano più. Gli anni Settanta presentano indubbi vantaggi per un Film Mibac. La politica seria, la piazza piena, un noi collettivo, la moto senza casco. Il cinema non ancora vampirizzato dalla tv. Un'«Italia vera», in canottiera con L'Unità sotto il braccio, da opporre all'indifferenza tatuata e depilata degli italiani post-cinematografici di oggi. Erano Anni felici, come li chiama Daniele Luchetti nel suo film. Avendoli vissuti da bambino chiede un contributo di novecentomila euro per raccontarci la storia della sua famiglia metà artistica, metà popolare. Ci regala almeno una scena memorabile. Kim Rossi Stewart, nudo, in trance dentro un happening alla Triennale di Milano che prende a pennellate le modelle, lo sguardo performativo perso tra pubi ricolmi di pelo, mentre irrompe nell'opera sua moglie, Micaela Ramazzoti mamma di Luchetti, che non capisce ma si adegua. Cose che se il Film Mibac non lo ambienti nei favolosi anni Settanta non te le puoi permettere. Lo spiegano bene anche alla recente mostra dell'Istituto Luce nel complesso del Vittoriano a Roma. Quando il visitatore sta per lasciare la stanza che racconta l'Italia degli anni Settanta, un cartello lo avverte: «Presto anche le fiammate giovanili si esauriranno e la neotelevisione imporrà i suoi linguaggi totalitari».
Il Film Mibac si fa coi soldi della televisione di Stato per combattere un'estenuante guerra di trincea contro la tv totalitaria. Una guerra iniziata nel lontano 1985, anno primo dell'era del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo). Ce lo spiega Valerio Jalongo, regista Mibac del documentario-inchiesta sul cinema italiano, Di me cosa ne sai? All'arrivo delle tv di Berlusconi, il Grande Cinema ha reagito con la creazione del FUS. Però non è bastato. Il documentario poi non trova il tempo di dire che dal 1996 al 2004, durante la gestione veltroniana del FUS, abbiamo speso quasi ottocento milioni di euro, cioè esaurito le casse, e portato nelle sale dei capolavori memorabili che ora non ricordo.
Il Film Mibac fa le denunce. Sabina Guzzanti chiede il finanziamento statale per un film sulla «trattativa» Stato-Mafia e ci regala, oltre che una limpida apologia del conflitto di interessi, un formidabile esempio dell'uso ricattatorio del «contenuto». Perché ammettiamo anche che non sia un bel film. Resta il fatto che è un film «necessario». E su «necessario» crollano tutti. Se lo Stato non mi dà i soldi ha paura della «verità». Vi monto una campagna sul Fatto, faccio firmare gli appelli, chiamo Rodotà. La logica del "contro-il-sistema" in Italia è un business e un ricatto psicologico di dimensioni rilevanti.
Poi c'è la donna Mibac. La donna Mibac è sempre in crisi. Se scrive, ha smesso di scrivere. Se non scrive, porta i figli a scuola. Se non ha figli, non riesce a rimanere incinta. Piange. Raramente lavora, ma se lavora è stronza, magra e nervosa, e allora chiamiamo Isabella Ferrari. Come nel Venditore di medicine, dove recita anche Marco Travaglio, e lei è più spettrale di Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club, ma invece di cercare le medicine cerca medici da corrompere. È un Film Mibac di nicchia. Mi portano a vederlo in un'arena all'aperto del Pigneto dove fanno il dibattito col microfono e le sedie di plastica. Siccome è del genere «film italiani che potevano essere puntate di Report», girano i nomi di Elio Petri, Francesco Rosi, la grande stagione del cinema politico, l'inchiesta. «Deve essere stato difficile fare un film del genere nell'Italia di oggi…», domandano al regista. Il regista fa la faccia di uno che vorrebbe dire «...ma guarda, veramente l'Italia di oggi mi ha dato comunque centocinquantamila euro per farlo», però giustamente sta al gioco. Dice che una clinica non ha rilasciato il permesso per le riprese. Ci autorizza tutti a pensare al complotto delle case farmaceutiche, al degrado morale della sanità, al traffico d'organi. Siamo indignati ma non abbiamo paura. Perché il Film Mibac è l'arma più forte. E torniamo tutti a casa tranquilli.



